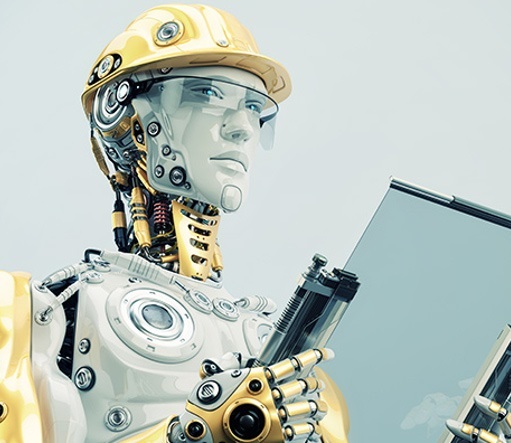
I profondi cambiamenti intervenuti in questi ultimi decenni in campo tecnologico e sociale hanno grandemente modificato la condizione del lavoro umano, sollevando una serie di questioni che hanno un’immediata ricaduta etica. Si è infatti assistito, da un lato, a un consistente peggioramento della vita dei ceti più deboli dovuto agli squilibri provocati dall’economia di mercato – un ruolo decisivo in tal senso è stato esercitato dal fenomeno della finanziarizzazione –; e all’avanzare, dall’altro, di una situazione di estrema precarietà dell’attività lavorativa, dovuta sia all’instabilità dell’occupazione sia al costante mutamento delle competenze e delle funzioni a causa delle trasformazioni indotte dalla rivoluzione tecnologica.
Dove va il lavoro?
Ad aggravare il disagio, alimentando uno stato di insicurezza psicologica hanno poi concorso (e concorrono) una condizione di pesante solitudine della classe operaia, sia per il venir meno di forme di solidarietà che creavano in passato vincoli molto forti tra le persone, sia per la mancanza di ammortizzatori sociali adeguati e di servizi efficienti, sia infine per l’indebolimento del sindacato, dovuto tanto alla riduzione del numero degli iscritti (anche per la oggettiva riduzione degli appartenenti alla classe operaia), quanto all’affermarsi all’interno di esso di spinte corporative con la tendenza a tutelare i diritti di chi è già garantito e la scarsa attenzione a chi non ha accesso al mercato del lavoro, le nuove generazioni in particolare.
Il momento di transizione, dovuto al passaggio dal vecchio sistema industriale alle avvisaglie del nuovo, non può che suscitare profonda inquietudine. Gli sviluppi della robotica, che prende sempre più il sopravvento con un ritmo accelerato nei diversi campi della produzione e dei servizi, oltre al pericolo di una drastica riduzione dei posti di lavoro per la sostituzione dell’uomo con la macchina, porta con sé il rischio della spersonalizzazione, e dunque della disumanizzazione, del lavoro, non solo manuale, ma anche intellettuale, in ragione della sua separazione dalla persona.
Nella società dei robot il lavoro tende infatti a perdere il carattere di rapporto del soggetto umano con se stesso, con la comunità di coloro che vi partecipano e con la stessa natura, e acquisisce vieppiù il carattere di «merce» – la tesi di Karl Marx riprende in proposito grande attualità – per una sempre maggiore sudditanza nei confronti di chi manovra le leve dell’economia e della finanza, ma anche per le crescenti differenze tra lavoratori altamente specializzati e lavoratori poco qualificati, i quali ultimi finiscono per andare soggetti a una forma di nuova schiavitù.
Il conflitto tra capitale e lavoro proprio del dominio del mercato capitalistico assume connotati nuovi e più accentuati per la ricerca da parte del potere finanziario di accelerare senza limiti il processo di robotizzazione e di incrementare i profitti a danno dei lavoratori.
La questione antropologica ed etica
L’attuale situazione non ha soltanto risvolti tecnici ed economici ma anche (e ancor più) antropologici ed etici. Il lavoro infatti non è solo mezzo di sostentamento; è anche (e soprattutto) fattore centrale della maturazione e qualificazione dell’essere umano, nonché della partecipazione alla vita sociale. Esso conserva la propria dignità solo nella misura in cui mantiene la qualità di atto veramente umano ed evita la caduta in forme di strumentalizzazione alienante. Il grande valore umano e personale del lavoro esige pertanto un’attenzione particolare a salvaguardarne l’identità, riaffermandone la centralità nell’esperienza della vita dell’uomo.
L’etica del lavoro, che riflette questa densità di significati antropologici, non può dunque che avere come criterio decisivo la scelta di privilegiare i bisogni delle persone rispetto ai profitti finanziari, avendo perciò di mira come priorità il benessere generale dei lavoratori, e in particolare la tutela dei loro diritti, nel rispetto della qualità dell’attività lavorativa e dell’ambiente.
In una situazione come quella descritta, che vede una crescente diminuzione (peraltro nella previsione del futuro ancora maggiore) dei posti e in presenza di forme di produzione che emarginano molte persone, un impegno di prim’ordine va riservato alla difesa del diritto del lavoro per tutti, sancito anche dalla nostra Costituzione, e alla creazione di condizioni sociali e giuridiche per la sua concreta attuazione.
La riforma dello Stato sociale (Welfare) non può prescindere dalla considerazione di questa emergenza e non promuovere, di conseguenza, incentivi adeguati a fornire ad essa una risposta efficace.
Ma questo non è sufficiente. L’etica del lavoro, oltre a doversi interrogare su che cosa produrre e come produrlo, nonché su come distribuire ciò che si è prodotto – è questa anzitutto la domanda obbligata se si intende venire incontro ai bisogni della parte meno privilegiata della popolazione – deve oggi anche interrogarsi sull’uso che si fa della tecnologia, la quale non è affatto «neutrale», ma costituisce, per la rilevanza assunta, una delle più grandi sfide dell’attuale momento storico.
La consapevolezza che non tutto ciò che è tecnicamente possibile è anche eticamente legittimo, e che si danno invece effetti pesantemente negativi non legati esclusivamente al cattivo uso che si fa della tecnica, bensì anche al dominio che essa può esercitare sull’esistenza, in quanto creatrice di una reale mutazione della coscienza o di una vera e propria rivoluzione antropologica, rende necessario l’esercizio di una permanente vigilanza. Al punto che vi è chi ritiene che occorra dar vita – è questa la tesi del filosofo Vittorio Possenti – in presenza dell’avanzare dell’intelligenza artificiale, ad «una moratoria globale per riprendere il controllo di noi stessi e dei rapporti sociali primari di fronte all’onnipotenza della tecnica e del mercato» (Robot, la tecnologia ci ruba il lavoro, “Avvenire”, 14 aprile 2019, p. 23).
Prospettive di impegno
Infine l’etica del lavoro non può ridursi a svolgere una funzione critica nei confronti della situazione odierna; deve anche preoccuparsi di fornire prospettive positive per il suo superamento o almeno impegnarsi ad indicare interventi concreti che consentano di ridurre le deficienze odierne e di segnalare le piste obbligate per uscire dall’impasse.
La prima condizione perché questo si verifichi è l’attivazione di una seria politica industriale, che riporti al centro la produzione di beni e di servizi, ridimensionando il potere del sistema finanziario, che deve tornare ad esercitare la funzione di strumento al servizio dell’economia reale.
Questo comporta anzitutto la presenza di un forte intervento pubblico nei confronti di una finanza aggressiva, che è la vera responsabile della crisi del 2008 e delle diseguaglianze sociali tuttora persistenti. È necessario fissare, al riguardo, regole precise che tutelino le istanze sociali e ambientali, garantendo un equilibrio all’interno del mercato mediante lo smantellamento di monopoli e oligopoli, che distruggono posti di lavoro e impediscono a nuovi imprenditori di interagire, minacciando in questo modo l’esercizio stesso della democrazia, la quale presuppone la possibilità reale della libera iniziativa. Non vi è nulla di meno libero infatti di un mercato liberista, nel quale è negata ai più la possibilità di accesso.
L’attuazione di questo disegno è strettamente legata alla restituzione di dignità e di efficacia alla politica. Si tratta di farle superare l’attuale stato di debolezza mediante l’abbandono della subordinazione ai cosiddetti poteri forti, economia in primis, e la capacità di andare oltre gli Stati nazione, che la rendono impotente di fronte a processi che vanno ben oltre le frontiere nazionali ed esigono interventi da parte di poteri più vasti e più autorevoli. L’assicurazione della qualità e dei diritti del lavoro, nonché la fornitura di solide garanzie sociali, suppone infatti l’attivazione di una politica internazionale che, nell’indirizzare gli investimenti, ponga in primo piano l’interesse generale e imponga precisi vincoli al mercato.
La seconda condizione è rappresentata dalla promulgazione di una legislazione del lavoro che, nella tutela dei diritti, si riferisca alla persona piuttosto che alle mansioni, e che sviluppi una forma di contrattazione inclusiva la quale faccia riferimento ad alcuni diritti essenziali da salvaguardare per tutti, e preveda, nello stesso tempo, forme differenziate di intervento a seconda del disagio, della pesantezza delle prestazioni e dei cicli di vita. Il consenso a questa logica comporta la scelta della contrattazione nazionale (meglio se europea) senza rinunciare a una contrattazione aziendale, che tenga in considerazione fattori di carattere locale, quali i diversi livelli di produttività, le oggettive difficoltà logistiche, e altro.
L’ultima condizione chiama in causa la questione già accennata dell’innovazione tecnologica. Qui la preoccupazione principale deve essere quella di dare corso ad attività produttive che sappiano misurarsi positivamente con le esigenze di carattere sociale e con l’impatto ambientale. Anche a questo proposito diviene imprescindibile il ricorso a una azione sovranazionale – per il nostro Paese anzitutto europea – che persegua risultati efficaci. Mettere in atto una politica dell’innovazione che si ispiri a questi indirizzi non ha soltanto come effetto quello di favorire un processo di crescita, volto a conciliare progresso tecnico e promozione umana, ma anche di fornire la garanzia di una effettiva onesta concorrenzialità.
La realizzazione di questo disegno ha bisogno che si sviluppi, in parallelo, la creazione di infrastrutture adeguate sia di carattere materiale (ferrovie, autostrade, porti ecc.) che sociale (sanità, istruzione, servizi ecc.), le quali rappresentano il presupposto necessario del successo di qualsiasi operazione economica.
L’adempimento di queste condizioni è la premessa irrinunciabile della restituzione al lavoro della sua dignità. Una premessa basilare per l’innesco di un processo che sta alla creatività dell’uomo promuovere, trasformando il lavoro da semplice strumento per l’autosostentamento o, peggio ancora, in «merce» che produce alienazione, in attività che favorisce la crescita della solidarietà sociale e che costituisce uno dei fattori più importanti del processo di una vera umanizzazione.
(Tratto da “Rocca”, rivista della Pro Civitate Christiana Assisi)
Dove va il lavoro?
Ad aggravare il disagio, alimentando uno stato di insicurezza psicologica hanno poi concorso (e concorrono) una condizione di pesante solitudine della classe operaia, sia per il venir meno di forme di solidarietà che creavano in passato vincoli molto forti tra le persone, sia per la mancanza di ammortizzatori sociali adeguati e di servizi efficienti, sia infine per l’indebolimento del sindacato, dovuto tanto alla riduzione del numero degli iscritti (anche per la oggettiva riduzione degli appartenenti alla classe operaia), quanto all’affermarsi all’interno di esso di spinte corporative con la tendenza a tutelare i diritti di chi è già garantito e la scarsa attenzione a chi non ha accesso al mercato del lavoro, le nuove generazioni in particolare.
Il momento di transizione, dovuto al passaggio dal vecchio sistema industriale alle avvisaglie del nuovo, non può che suscitare profonda inquietudine. Gli sviluppi della robotica, che prende sempre più il sopravvento con un ritmo accelerato nei diversi campi della produzione e dei servizi, oltre al pericolo di una drastica riduzione dei posti di lavoro per la sostituzione dell’uomo con la macchina, porta con sé il rischio della spersonalizzazione, e dunque della disumanizzazione, del lavoro, non solo manuale, ma anche intellettuale, in ragione della sua separazione dalla persona.
Nella società dei robot il lavoro tende infatti a perdere il carattere di rapporto del soggetto umano con se stesso, con la comunità di coloro che vi partecipano e con la stessa natura, e acquisisce vieppiù il carattere di «merce» – la tesi di Karl Marx riprende in proposito grande attualità – per una sempre maggiore sudditanza nei confronti di chi manovra le leve dell’economia e della finanza, ma anche per le crescenti differenze tra lavoratori altamente specializzati e lavoratori poco qualificati, i quali ultimi finiscono per andare soggetti a una forma di nuova schiavitù.
Il conflitto tra capitale e lavoro proprio del dominio del mercato capitalistico assume connotati nuovi e più accentuati per la ricerca da parte del potere finanziario di accelerare senza limiti il processo di robotizzazione e di incrementare i profitti a danno dei lavoratori.
La questione antropologica ed etica
L’attuale situazione non ha soltanto risvolti tecnici ed economici ma anche (e ancor più) antropologici ed etici. Il lavoro infatti non è solo mezzo di sostentamento; è anche (e soprattutto) fattore centrale della maturazione e qualificazione dell’essere umano, nonché della partecipazione alla vita sociale. Esso conserva la propria dignità solo nella misura in cui mantiene la qualità di atto veramente umano ed evita la caduta in forme di strumentalizzazione alienante. Il grande valore umano e personale del lavoro esige pertanto un’attenzione particolare a salvaguardarne l’identità, riaffermandone la centralità nell’esperienza della vita dell’uomo.
L’etica del lavoro, che riflette questa densità di significati antropologici, non può dunque che avere come criterio decisivo la scelta di privilegiare i bisogni delle persone rispetto ai profitti finanziari, avendo perciò di mira come priorità il benessere generale dei lavoratori, e in particolare la tutela dei loro diritti, nel rispetto della qualità dell’attività lavorativa e dell’ambiente.
In una situazione come quella descritta, che vede una crescente diminuzione (peraltro nella previsione del futuro ancora maggiore) dei posti e in presenza di forme di produzione che emarginano molte persone, un impegno di prim’ordine va riservato alla difesa del diritto del lavoro per tutti, sancito anche dalla nostra Costituzione, e alla creazione di condizioni sociali e giuridiche per la sua concreta attuazione.
La riforma dello Stato sociale (Welfare) non può prescindere dalla considerazione di questa emergenza e non promuovere, di conseguenza, incentivi adeguati a fornire ad essa una risposta efficace.
Ma questo non è sufficiente. L’etica del lavoro, oltre a doversi interrogare su che cosa produrre e come produrlo, nonché su come distribuire ciò che si è prodotto – è questa anzitutto la domanda obbligata se si intende venire incontro ai bisogni della parte meno privilegiata della popolazione – deve oggi anche interrogarsi sull’uso che si fa della tecnologia, la quale non è affatto «neutrale», ma costituisce, per la rilevanza assunta, una delle più grandi sfide dell’attuale momento storico.
La consapevolezza che non tutto ciò che è tecnicamente possibile è anche eticamente legittimo, e che si danno invece effetti pesantemente negativi non legati esclusivamente al cattivo uso che si fa della tecnica, bensì anche al dominio che essa può esercitare sull’esistenza, in quanto creatrice di una reale mutazione della coscienza o di una vera e propria rivoluzione antropologica, rende necessario l’esercizio di una permanente vigilanza. Al punto che vi è chi ritiene che occorra dar vita – è questa la tesi del filosofo Vittorio Possenti – in presenza dell’avanzare dell’intelligenza artificiale, ad «una moratoria globale per riprendere il controllo di noi stessi e dei rapporti sociali primari di fronte all’onnipotenza della tecnica e del mercato» (Robot, la tecnologia ci ruba il lavoro, “Avvenire”, 14 aprile 2019, p. 23).
Prospettive di impegno
Infine l’etica del lavoro non può ridursi a svolgere una funzione critica nei confronti della situazione odierna; deve anche preoccuparsi di fornire prospettive positive per il suo superamento o almeno impegnarsi ad indicare interventi concreti che consentano di ridurre le deficienze odierne e di segnalare le piste obbligate per uscire dall’impasse.
La prima condizione perché questo si verifichi è l’attivazione di una seria politica industriale, che riporti al centro la produzione di beni e di servizi, ridimensionando il potere del sistema finanziario, che deve tornare ad esercitare la funzione di strumento al servizio dell’economia reale.
Questo comporta anzitutto la presenza di un forte intervento pubblico nei confronti di una finanza aggressiva, che è la vera responsabile della crisi del 2008 e delle diseguaglianze sociali tuttora persistenti. È necessario fissare, al riguardo, regole precise che tutelino le istanze sociali e ambientali, garantendo un equilibrio all’interno del mercato mediante lo smantellamento di monopoli e oligopoli, che distruggono posti di lavoro e impediscono a nuovi imprenditori di interagire, minacciando in questo modo l’esercizio stesso della democrazia, la quale presuppone la possibilità reale della libera iniziativa. Non vi è nulla di meno libero infatti di un mercato liberista, nel quale è negata ai più la possibilità di accesso.
L’attuazione di questo disegno è strettamente legata alla restituzione di dignità e di efficacia alla politica. Si tratta di farle superare l’attuale stato di debolezza mediante l’abbandono della subordinazione ai cosiddetti poteri forti, economia in primis, e la capacità di andare oltre gli Stati nazione, che la rendono impotente di fronte a processi che vanno ben oltre le frontiere nazionali ed esigono interventi da parte di poteri più vasti e più autorevoli. L’assicurazione della qualità e dei diritti del lavoro, nonché la fornitura di solide garanzie sociali, suppone infatti l’attivazione di una politica internazionale che, nell’indirizzare gli investimenti, ponga in primo piano l’interesse generale e imponga precisi vincoli al mercato.
La seconda condizione è rappresentata dalla promulgazione di una legislazione del lavoro che, nella tutela dei diritti, si riferisca alla persona piuttosto che alle mansioni, e che sviluppi una forma di contrattazione inclusiva la quale faccia riferimento ad alcuni diritti essenziali da salvaguardare per tutti, e preveda, nello stesso tempo, forme differenziate di intervento a seconda del disagio, della pesantezza delle prestazioni e dei cicli di vita. Il consenso a questa logica comporta la scelta della contrattazione nazionale (meglio se europea) senza rinunciare a una contrattazione aziendale, che tenga in considerazione fattori di carattere locale, quali i diversi livelli di produttività, le oggettive difficoltà logistiche, e altro.
L’ultima condizione chiama in causa la questione già accennata dell’innovazione tecnologica. Qui la preoccupazione principale deve essere quella di dare corso ad attività produttive che sappiano misurarsi positivamente con le esigenze di carattere sociale e con l’impatto ambientale. Anche a questo proposito diviene imprescindibile il ricorso a una azione sovranazionale – per il nostro Paese anzitutto europea – che persegua risultati efficaci. Mettere in atto una politica dell’innovazione che si ispiri a questi indirizzi non ha soltanto come effetto quello di favorire un processo di crescita, volto a conciliare progresso tecnico e promozione umana, ma anche di fornire la garanzia di una effettiva onesta concorrenzialità.
La realizzazione di questo disegno ha bisogno che si sviluppi, in parallelo, la creazione di infrastrutture adeguate sia di carattere materiale (ferrovie, autostrade, porti ecc.) che sociale (sanità, istruzione, servizi ecc.), le quali rappresentano il presupposto necessario del successo di qualsiasi operazione economica.
L’adempimento di queste condizioni è la premessa irrinunciabile della restituzione al lavoro della sua dignità. Una premessa basilare per l’innesco di un processo che sta alla creatività dell’uomo promuovere, trasformando il lavoro da semplice strumento per l’autosostentamento o, peggio ancora, in «merce» che produce alienazione, in attività che favorisce la crescita della solidarietà sociale e che costituisce uno dei fattori più importanti del processo di una vera umanizzazione.
(Tratto da “Rocca”, rivista della Pro Civitate Christiana Assisi)
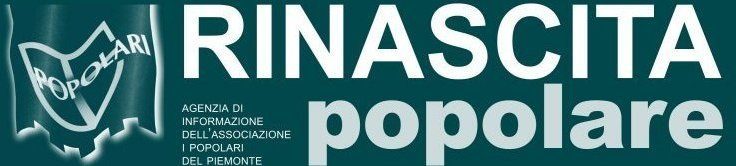
La politica, secondo quanto detto dal cardinale Biffi di venerata memoria, non è l’arte del possibile, ma l’arte di rendere possibile il necessario.
Il lungo articolo del dott. Piana, apprezzabile come autorevole auspicio, nulla dice di come rendere accettabili senza forzature violente le proposte ideali nella società odierna.
Per un rapporto corretto e non subalterno verso la tecnologia bisogna innanzitutto conoscerla ed ecco la funzione della scuola. Bisogna anche che la scuola non si limiti ad insegnare come si fa, ma perchè si fa e dia anche agli studenti tecnici le basi umanistiche per non perdere il minimo indispensabile di capacità critica.
Se i prodotti della tecnologia sono in Italia non solo usati, ma anche progettati e costruiti, si attenuerà l’impatto negativo sui livelli occupazionali e la fuga all’estero dei lavoratori più qualificati.
E quelli che non ce la fanno? In Italia esistono tante e tali emergenze ambientali che, se solo i politici avessero il coraggio della verità, non ci sarebbe problema a trovare lavoro a tutta la manodopera senza qualifiche. Bisognerebbe però, invece di promettere riduzioni di tasse che mai nessuno ottiene, dire con precisione come si spenderanno i soldi (ammesso che il popolo desideri la verità e non piuttosto le illusioni).