
Il Presidente della Repubblica ha inaugurato oggi a Roma l’anno accademico dell’Università LUISS “Guido Carli”. Nel suo discorso Sergio Mattarella si è dimostrato come sempre un punto di riferimento. Per comprendere la realtà ha esortato alla “capacità di studio, di approfondimento”, e a “rifuggire dall’approssimazione, dall’improvvisazione: elementi di cui il nostro Paese – studio, approfondimento, capacità di esaminare le questioni nella loro realtà – ha grande bisogno”. Poi, riprendendo la figura di Narciso che si isola contemplando la sua immagine, ne trae “un insegnamento anche per i nostri tempi in cui emergono tentazioni di chiusura in se stessi, per individui, per gruppi sociali, per realtà nazionali, che richiedono una riflessione adeguata, storicamente all’altezza del momento”. E segnaliamo ancora il passaggio sulla “consapevolezza dell’unicità della cultura. Non esistono due culture, una umanistica e l’altra scientifica. La cultura ha una sua irriducibile unicità”.
Di seguito potete leggere l’intervento completo.
Desidero rivolgere un saluto molto cordiale a tutti, alla Presidente e al Rettore di questo Ateneo, al Direttore generale, ai rappresentanti degli studenti, al Presidente della Conferenza dei Rettori e, con lui, ai Rettori presenti, in numero così ampio, propedeutico a un incontro che raffigura plasticamente l’importanza del sistema accademico del nostro Paese, come è stato ampiamente detto dal Presidente della Conferenza.
Un saluto al Corpo accademico e, soprattutto, alle studentesse e agli studenti.
Un ringraziamento molto intenso alla Professoressa Lahiri e al Professor Italiano che hanno affrontato argomenti e sottoposto alla nostra attenzione riflessioni tutt’altro che distanti tra di loro.
Dalle parole del Rettore, del Direttore generale e della Presidente, abbiamo ascoltato la raffigurazione di questo Ateneo i cui numeri sono significativi: il numero degli studenti, il rapporto tra docenti e studenti, i corsi tenuti in inglese, l’apertura agli studenti di altri Paesi e dei nostri studenti e studentesse verso il mondo, il tasso di occupazione dei laureati di questo Ateneo.
Il Professor Manfredi ci ha esposto le sue riflessioni sul ruolo della nostra Università e sul ruolo indispensabile da coltivare, sviluppare e accrescere, che richiede un sostegno adeguato da parte delle istituzioni.
Vorrei rivolgermi agli elementi centrali di questa mattina: la lectio magistralis e la prolusione che si sono svolte, senza dimenticare che i numeri di questo Ateneo hanno sottolineato quanto diceva il rappresentante degli studenti, parlando della capacità di attenzione e di comprendere la realtà. Ciò vuol dire, tradotta in concreto, capacità di studio, di approfondimento, di rifuggire dall’approssimazione, dall’improvvisazione: elementi di cui il nostro Paese – studio, approfondimento, capacità di esaminare le questioni nella loro realtà – ha grande bisogno.
La professoressa Lahiri ci ha sottoposto una quantità di riflessioni e di spunti di riflessione che sono tanti e non posso riprenderli tutti. Suggestivo l’accostamento del traduttore Eco. In realtà, nel suo splendido italiano, lei ha reso evidente la creatività del traduttore, come il traduttore sia, insieme all’autore, un autore del testo tradotto, perché – come lei ha detto – senza comprenderlo, viverlo, immedesimarsi in quel testo, sarebbe impossibile tradurlo con efficacia e con successo.
Ha anche fatto una riflessione sul rapporto tra Narciso ed Eco. Lei ha accostato Narciso che si specchia in se stesso alla tendenza di individui - ma anche di collettività, anche di Paesi - di chiudersi in se stessi, di rifiutare quel che fa un traduttore che, traducendo un testo da una lingua all’altra, in realtà abbatte una frontiera, la supera e collega realtà diverse tra di loro che tanto diverse in definitiva non sono, come emerge dalla traduzione.
Narciso invece si chiude in se stesso, esaurisce se stesso in questa contemplazione e si annulla in questa chiusura in se stesso.
Sono due isolamenti, quelli che ci ha descritto la Professoressa Lahiri: quello di Eco, isolamento subito e non voluto, e quello di Narciso, isolamento voluto e ricercato dall’interessato.
È un insegnamento anche per i nostri tempi in cui emergono tentazioni di chiusura in se stessi, per individui, per gruppi sociali, per realtà nazionali, che richiedono una riflessione adeguata, storicamente all’altezza del momento, in tutti i Paesi.
Il Professor Italiano ci ha raffigurato l’affascinante prospettiva dell’intelligenza artificiale. Io non condivido quel filo di inquietudine che alcuni avvertono di fronte a queste prospettive che, accanto all’aspetto affascinante, vi sia qualche profilo inquietante. Io non credo che sia così: il progresso, comunque sia, è altamente positivo e da cogliere in tutta la sua valenza positiva, naturalmente tenendo sempre conto del senso dei risultati, dei limiti dei risultati, dell’esigenza di regolarli.
Il dibattito che inizia a svilupparsi sulla soggettività dei cervelli artificiali, degli androidi, addirittura sulla personalità giuridica di questi nuovi soggetti, richiede un’adeguata riflessione e la percezione del limite di un’intelligenza, anche acuta, veloce, molto più veloce di quella umana, verosimilmente, come nei fatti è dimostrato dagli esperimenti, ma separata da tutto il resto degli elementi che compongono la persona umana.
In realtà quello che ci ha raffigurato il Professor Italiano è l’esigenza di non scorporare il sapere delle discipline, di non separarle. Non c’è, e non può mai essere accantonata, la percezione e la consapevolezza dell’unicità della cultura. Non esistono due culture, una umanistica e l’altra scientifica. La cultura ha una sua irriducibile unicità; e la stessa sottolineatura che il Professor Italiano ha fatto all’esigenza di interrelazione, di esame congiunto tra le varie prospettive, ne è una dimostrazione.
In fondo è quello che dice l’articolo 9 della nostra Costituzione, che è stato letto da qualcuno come operante una distinzione tra cultura e ricerca scientifica. Al contrario, una sua attenta lettura fa percepire come il Costituente abbia inteso la cultura nel suo complesso – sia essa definita scientifica o umanistica - e che la ricerca scientifica riguardi tutte le branche, tutte le forme e le espressioni della cultura. È la cultura patrimonio da un lato e la cultura dinamica nella ricerca scientifica dall’altro, ma sempre nell’unicità del patrimonio culturale.
E questo è un patrimonio che i nostri atenei conservano, custodiscono trasmettono, alimentano e sviluppano, e per questo siamo grati a ciò che fanno i nostri Atenei, in particolare a questo, oggi.
Di seguito potete leggere l’intervento completo.
Desidero rivolgere un saluto molto cordiale a tutti, alla Presidente e al Rettore di questo Ateneo, al Direttore generale, ai rappresentanti degli studenti, al Presidente della Conferenza dei Rettori e, con lui, ai Rettori presenti, in numero così ampio, propedeutico a un incontro che raffigura plasticamente l’importanza del sistema accademico del nostro Paese, come è stato ampiamente detto dal Presidente della Conferenza.
Un saluto al Corpo accademico e, soprattutto, alle studentesse e agli studenti.
Un ringraziamento molto intenso alla Professoressa Lahiri e al Professor Italiano che hanno affrontato argomenti e sottoposto alla nostra attenzione riflessioni tutt’altro che distanti tra di loro.
Dalle parole del Rettore, del Direttore generale e della Presidente, abbiamo ascoltato la raffigurazione di questo Ateneo i cui numeri sono significativi: il numero degli studenti, il rapporto tra docenti e studenti, i corsi tenuti in inglese, l’apertura agli studenti di altri Paesi e dei nostri studenti e studentesse verso il mondo, il tasso di occupazione dei laureati di questo Ateneo.
Il Professor Manfredi ci ha esposto le sue riflessioni sul ruolo della nostra Università e sul ruolo indispensabile da coltivare, sviluppare e accrescere, che richiede un sostegno adeguato da parte delle istituzioni.
Vorrei rivolgermi agli elementi centrali di questa mattina: la lectio magistralis e la prolusione che si sono svolte, senza dimenticare che i numeri di questo Ateneo hanno sottolineato quanto diceva il rappresentante degli studenti, parlando della capacità di attenzione e di comprendere la realtà. Ciò vuol dire, tradotta in concreto, capacità di studio, di approfondimento, di rifuggire dall’approssimazione, dall’improvvisazione: elementi di cui il nostro Paese – studio, approfondimento, capacità di esaminare le questioni nella loro realtà – ha grande bisogno.
La professoressa Lahiri ci ha sottoposto una quantità di riflessioni e di spunti di riflessione che sono tanti e non posso riprenderli tutti. Suggestivo l’accostamento del traduttore Eco. In realtà, nel suo splendido italiano, lei ha reso evidente la creatività del traduttore, come il traduttore sia, insieme all’autore, un autore del testo tradotto, perché – come lei ha detto – senza comprenderlo, viverlo, immedesimarsi in quel testo, sarebbe impossibile tradurlo con efficacia e con successo.
Ha anche fatto una riflessione sul rapporto tra Narciso ed Eco. Lei ha accostato Narciso che si specchia in se stesso alla tendenza di individui - ma anche di collettività, anche di Paesi - di chiudersi in se stessi, di rifiutare quel che fa un traduttore che, traducendo un testo da una lingua all’altra, in realtà abbatte una frontiera, la supera e collega realtà diverse tra di loro che tanto diverse in definitiva non sono, come emerge dalla traduzione.
Narciso invece si chiude in se stesso, esaurisce se stesso in questa contemplazione e si annulla in questa chiusura in se stesso.
Sono due isolamenti, quelli che ci ha descritto la Professoressa Lahiri: quello di Eco, isolamento subito e non voluto, e quello di Narciso, isolamento voluto e ricercato dall’interessato.
È un insegnamento anche per i nostri tempi in cui emergono tentazioni di chiusura in se stessi, per individui, per gruppi sociali, per realtà nazionali, che richiedono una riflessione adeguata, storicamente all’altezza del momento, in tutti i Paesi.
Il Professor Italiano ci ha raffigurato l’affascinante prospettiva dell’intelligenza artificiale. Io non condivido quel filo di inquietudine che alcuni avvertono di fronte a queste prospettive che, accanto all’aspetto affascinante, vi sia qualche profilo inquietante. Io non credo che sia così: il progresso, comunque sia, è altamente positivo e da cogliere in tutta la sua valenza positiva, naturalmente tenendo sempre conto del senso dei risultati, dei limiti dei risultati, dell’esigenza di regolarli.
Il dibattito che inizia a svilupparsi sulla soggettività dei cervelli artificiali, degli androidi, addirittura sulla personalità giuridica di questi nuovi soggetti, richiede un’adeguata riflessione e la percezione del limite di un’intelligenza, anche acuta, veloce, molto più veloce di quella umana, verosimilmente, come nei fatti è dimostrato dagli esperimenti, ma separata da tutto il resto degli elementi che compongono la persona umana.
In realtà quello che ci ha raffigurato il Professor Italiano è l’esigenza di non scorporare il sapere delle discipline, di non separarle. Non c’è, e non può mai essere accantonata, la percezione e la consapevolezza dell’unicità della cultura. Non esistono due culture, una umanistica e l’altra scientifica. La cultura ha una sua irriducibile unicità; e la stessa sottolineatura che il Professor Italiano ha fatto all’esigenza di interrelazione, di esame congiunto tra le varie prospettive, ne è una dimostrazione.
In fondo è quello che dice l’articolo 9 della nostra Costituzione, che è stato letto da qualcuno come operante una distinzione tra cultura e ricerca scientifica. Al contrario, una sua attenta lettura fa percepire come il Costituente abbia inteso la cultura nel suo complesso – sia essa definita scientifica o umanistica - e che la ricerca scientifica riguardi tutte le branche, tutte le forme e le espressioni della cultura. È la cultura patrimonio da un lato e la cultura dinamica nella ricerca scientifica dall’altro, ma sempre nell’unicità del patrimonio culturale.
E questo è un patrimonio che i nostri atenei conservano, custodiscono trasmettono, alimentano e sviluppano, e per questo siamo grati a ciò che fanno i nostri Atenei, in particolare a questo, oggi.
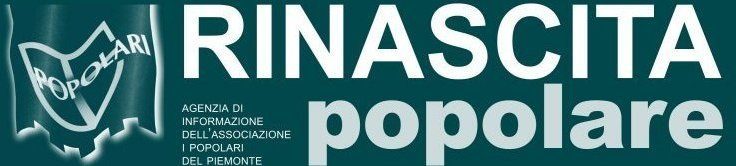
Lascia un commento